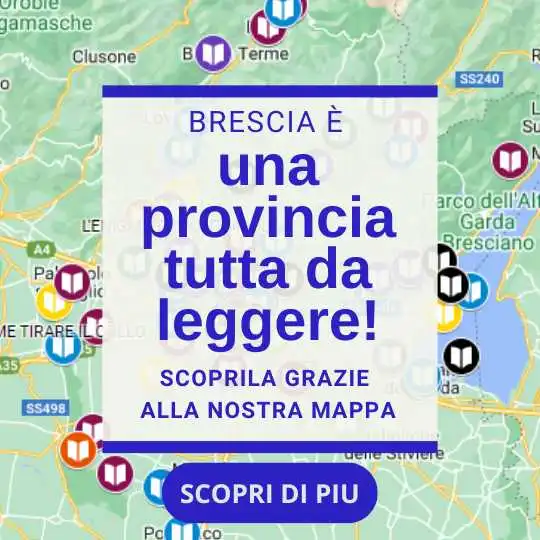“La città esclusa”: la questione carceraria a Brescia nel XIX secolo nella nuova edizione del saggio di Giancarlo Zappa

Letto e recensito da Roberto Bonzi per Brescia si legge
Come si potesse uscire ravveduti dalle carceri dell’epoca, costituisce un problema ed una domanda inquietante, che purtroppo ottiene una risposta negativa.
Giancarlo Zappa, La città esclusa, pag. 19
La fiducia in un carcere “utile” è alla base del pensiero di Giancarlo Zappa, “il padre dell’ordinamento penitenziario”. Così lo definisce Monica Calli, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, nell’introduzione alla nuova edizione de “La città esclusa” (Vannini Editrice, 2023), volume pubblicato in origine nel 2000 per la casa editrice La Quadra, in cui il magistrato analizza il rapporto tra comunità bresciana e questione carceraria nel XIX secolo, tracciando la propria visione del sistema penitenziario.
“Il carcere tradizionale, isolato, demonizzato, rifiutato era ed è l’università del crimine e rende così un pessimo servizio alla società”, sostiene Zappa che, dal 1987 al 1997, è stato responsabile della magistratura di Sorveglianza a Brescia. Per l’ordinamento erano anni di grande sperimentazione. Solo a partire dal 1975, infatti, l’esecuzione delle pene detentive iniziò a essere sottoposta alla vigilanza di un magistrato a tempo pieno, con una prima apertura concreta alle misure alternative al carcere.
La ristampa de “La città esclusa”, curata da Silvana Bini e Claudio Cambedda, riporta all’attenzione che merita il pensiero di Giancarlo Zappa, a testimonianza di una fase storica in cui la piena attuazione all’articolo 27 della Costituzione era un obiettivo condiviso da ampi segmenti della magistratura e delle istituzioni. La pena, intesa come “fatto sociale” e finalizzata alla rieducazione, appariva un traguardo possibile, da rivendicare nell’interesse dell’intera comunità. A distanza di anni, quella stagione sembra irrimediabilmente conclusa. Eppure le esigenze che la muovevano rimangono intatte anche nell’Italia di oggi, così come le criticità umanitarie e logistiche del sistema carcerario.
Il problema penitenziario nella Brescia del XIX secolo
Nel corso del XIX secolo a Brescia esistevano cinque strutture destinate a soddisfare le esigenze del settore penal-penitenziario, nessuna delle quali realizzata per tale scopo. Si trattava di edifici di proprietà pubblica già adibiti ad altri usi e poi adattati alla meglio, immersi nel centro storico: esistevano tutte le premesse per creare una situazione negativa fin dall’origine in fatto di sicurezza e d’igiene.
Giancarlo Zappa, La città esclusa, pag. 142
Giancarlo Zappa nasce il 2 gennaio 1930 a Tavernole sul Mella, in Valtrompia. Dopo la maturità classica al liceo Bagatta di Desenzano, si laurea in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano. In magistratura dal 1957, ricopre, tra le altre, le cariche di Giudice del Tribunale di Bergamo (1957-58), Sostituto Procuratore della Repubblica a Brescia (1967), Consigliere di Corte d’Appello (1976), Magistrato di Sorveglianza (1978), Magistrato di Corte di Cassazione (1986), Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia (1987-1997). Oltre a collaborare con numerose riviste giuridiche, partecipa ai lavori a supporto della “Legge Gozzini” (legge n. 663 del 1986), una delle riforme orientate a valorizzare l’aspetto rieducativo della carcerazione rispetto a quello punitivo. Giancarlo Zappa muore a Brescia il 10 febbraio 2004. Nel giugno del 2015 gli viene intitolata un’aula del Palazzo di Giustizia di Brescia, mentre dall’anno successivo il suo nome è inserito nel Monumento ai Cittadini Illustri di Brescia presso il Famedio, nel Pantheon del Campo Santo Vantini.
“La città esclusa” è il frutto di anni di ricerche e riflessioni. Il saggio offre una disamina puntuale e documentata di come la comunità bresciana del XIX secolo ha gestito il problema carcerario. L’analisi parte dall”organizzazione penitenziaria del Regno d’Italia. Fin dal primo regolamento generale del 1861, il nuovo stato unitario si diede l’obiettivo di uniformare i modelli dei vari Stati preunitari, ispirandosi a quello sardo-piemontese. Zappa analizza l’evoluzione della struttura organizzativa, dal peso effettivo dei direttori alla gestione del personale di servizio, dall’assistenza sanitaria al ruolo dei cappellani carcerari. Nell’impostazione ottocentesca, il carcere è visto come luogo di isolamento estremo. Ogni comunicazione con l’esterno veniva limitata allo stretto indispensabile: due lettere a settimana e un solo colloquio di mezz’ora con i parenti. L’assenza di contatti umani era concepita come parte essenziale della pena.
Un tema chiave è quello della vigilanza. Viene ricostruito nel dettaglio l’operato delle prime commissioni visitatrici che segnalavano a Sindaco e Prefetto gli inconvenienti rilevati nelle strutture carcerarie. Gli stralci di verbale e gli scambi epistolari citati nel volume sono una lettura molto istruttiva per comprendere le condizioni di vita all’interno delle carceri e le difficoltà che incontra da sempre chi tenta di portarle alla luce.
Il sostegno a “carcerati e liberati dal carcere” era affidato alla filantropia e al volontariato. Le ricerche di Zappa documentano il ruolo delle società di patronato, realtà laiche che, anche a Brescia, si affiancano alle opere pie della Chiesa con l’obiettivo di “raccogliere gli infelici uscenti dal carcere, di riformarne il morale, di restituirli alla società ed alla Patria, procacciando loro un’occupazione onorata”.
Il volume ricostruisce nel dettaglio l’evoluzione delle strutture penitenziarie a Brescia, dalle carceri ricavate in edifici del centro storico tra cui Palazzo Broletto (lato sud) a quelle del Castello, fino ad arrivare alla costruzione del Carcere di Canton Mombello, inaugurato nel 1914 al termine di un tortuoso iter politico e burocratico. Non a caso Zappa sceglie di concludere il saggio con un resoconto delle numerose sedute del Consiglio comunale di Brescia dedicate al progetto del nuovo edificio.
L’osmosi tra carcere e territorio
Bisogna cessare di costruire muri e scavare fosse, bisogna ottenere la pace sociale attraverso la collaborazione di tutti.
Giancarlo Zappa, La città esclusa
Per Giancarlo Zappa la criminalità è, nella sua essenza, un problema sociale. L’azione repressiva deve quindi accompagnarsi a quella preventiva. La difesa della sicurezza passa anche dalla tutela dei bisogni, attraverso un’offerta di servizi efficienti e il ruolo attivo del Terzo settore. Anche l’esecuzione della pena deve essere considerata un “fatto sociale”. Ridotto a mero strumento punitivo e luogo di espiazione, il carcere fallisce tutti i suoi obiettivi: il recupero delle persone condannate, ma anche la reale sicurezza della società.
“Il diritto penale deve trovare il coraggio per sperimentare strade nuove”, scrive Zappa. La suggestiva immagine che utilizza è quella di una sorta di osmosi tra carcere e territorio. Tra le strutture penitenziarie e le comunità dove sorgono può nascere un rapporto di vero e proprio scambio, da sviluppare nell’interesse reciproco: da una parte, avere una occasione vera di reinserimento nella società; dall’altra, affrontare alla radice il fenomeno criminale.
Un patrimonio di nuovi principi
A più di vent’anni dalla prima edizione, “La città esclusa” interroga più che mai la società di oggi. Una prima risposta è nei numeri. Nel 2024 i suicidi nelle carceri italiane sono stati 83, il dato più alto di sempre (Fonte: Ministero della Giustizia), mentre le persone detenute sono 62mila, a fronte di una capienza effettiva di 47mila. Nell’Italia di oggi, tornare a ragionare senza preconcetti sulla realtà delle carceri è un’operazione ostica e impopolare, ma quanto mai necessaria. Vale a maggior ragione per una città come Brescia, tra le poche a ospitare una struttura penitenziaria al limitare del centro storico.
Nel 2002, in occasione del conferimento del Premio Bulloni, dedicato dalla città di Brescia alle persone che si siano distinte per gesti di bontà verso la comunità, non potendo intervenire alla premiazione, Giancarlo Zappa inviò una lettera. “Bisogna dare tempo alla compagine civile di inserire nel proprio patrimonio genetico i nuovi principi”, scriveva. “Questo richiede l’impegno di più generazioni”. Anche per quelle di oggi, “La città esclusa” è un indispensabile punto di partenza.

Titolo: La città esclusa. La comunità bresciana di fronte al problema penitenziario nel secolo XIX
Autore: Giancarlo Zappa
Curatrice e curatore della ristampa: Silvana Bini e Claudio Cambedda
Editore: Vannini Editrice
Anno: 2023
Genere: saggio
Pagine: 248
ISBN: 9788864460840
Incontrarci non è stato facile, ora non perdiamoci di vista! Iscriviti alla nostra newsletter per essere aggiornato su ciò che accade sulla “scena letteraria bresciana”